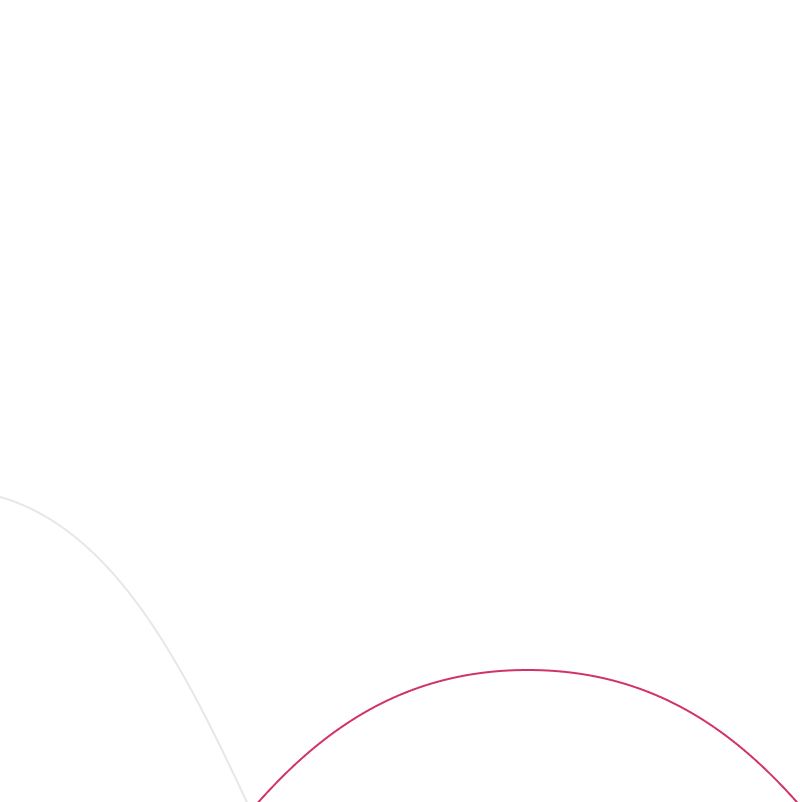L’ossigenoterapia iperbarica si è rilevata un valido aiuto per il recupero della capacità uditiva in caso di ipoacusia improvvisa, sia utilizzata contemporaneamente alla terapia farmacologica, sia utilizzata successivamente in pazienti che non hanno ricevuto beneficio dal trattamento farmacologico.
Per sordità improvvisa si intende una perdita uditiva superiore ai 30 dB che interessa almeno tre frequenze e che si instaura nell’arco di 24-72 ore. Questa patologia ha un’incidenza che varia tra i 10 e i 20 casi per 100.000 persone l’anno. In un numero ristretto di soggetti può interessare entrambe le orecchie nel giro di poche ore. L’età più colpita è tra i 50 e i 60 anni senza, apparentemente, alcuna differenza di sesso.
 Trova il centro Amplifon più vicino a te
Trova il centro Amplifon più vicino a te
Il tasso di guarigione spontanea dall'ipoacusia improvvisa è di circa il 50%. Ciò significa che in circa la metà delle persone colpite, la perdita dell'udito migliora gradualmente senza necessità di interventi, spesso entro 24 ore. Altri sperimentano un miglioramento durante la terapia. La perdita dell'udito improvvisa dura al massimo 14 giorni. Durante questo periodo, l'orecchio interessato dovrebbe migliorare.
La durata del trattamento dell'ipoacusia improvvisa e, di conseguenza, i tempi di recupero, possono variare notevolmente da persona a persona. In alcuni casi, il recupero dell'udito può avvenire rapidamente con il trattamento adeguato, mentre in altri casi i sintomi possono persistere per un periodo più prolungato o possono diventare permanenti. Questo perché il decorso della perdita dell'udito improvvisa può essere influenzato da una serie di fattori individuali, tra cui la gravità della condizione, la tempestività del trattamento, la salute generale dell'individuo e la risposta personale alla terapia.

L'ipoacusia improvvisa monolaterale, ovvero la perdita improvvisa dell'udito che coinvolge un solo orecchio, è una condizione uditiva che richiede un'attenta valutazione e gestione. Poiché può essere associata a una varietà di cause, è importante che venga eseguita una diagnosi accurata per determinare il trattamento più appropriato. Fra le cause dell'ipoacusia improvvisa monolaterale ci sono:
Il trattamento dell'ipoacusia improvvisa monolaterale dipende dalla causa sottostante e dalla gravità della perdita uditiva. Le opzioni di trattamento includono terapie farmacologiche, interventi chirurgici, terapie di riabilitazione uditiva o dispositivi uditivi come apparecchi acustici o impianti cocleari.
L'ipoacusia improvvisa recidiva si verifica quando una persona sperimenta una perdita improvvisa dell'udito più di una volta nel corso della sua vita. Questo fenomeno può essere frustrante e preoccupante per chi lo vive, poiché può indicare una condizione sottostante più complessa o ricorrente. Le cause della ricorrenza dell'ipoacusia improvvisa possono variare, fra esse ci sono:
L'ipoacusia improvvisa, un disturbo dell'udito che può manifestarsi in modo repentino e senza alcun preavviso, è spesso associata a una serie di cause potenziali, tra cui lo stress cronico. Quest'ultimo può giocare un ruolo significativo nel suo sviluppo attraverso vari meccanismi fisiologici.
In particolare, un prolungato stato di stress può innescare una produzione eccessiva di adrenalina, un ormone che regola la risposta del corpo agli eventi stressanti. Questo aumento di adrenalina può influenzare la circolazione sanguigna generale, compreso il microcircolo nell'orecchio interno. La compromissione della circolazione può causare danni alle delicate cellule ciliate dell'orecchio interno, responsabili della trasduzione dei suoni in segnali nervosi. In casi estremi, la circolazione compromessa può portare al completo blocco del flusso sanguigno, provocando danni irreversibili alle cellule ciliate.
Se lo stress cronico persiste nel tempo, il danno alle cellule ciliate può diventare permanente, compromettendo in modo significativo la capacità uditiva dell'individuo. Pertanto, è importante considerare il ruolo dello stress nella diagnosi e nel trattamento della perdita dell'udito improvvisa, affrontando non solo i sintomi uditivi ma anche le cause sottostanti di stress cronico per prevenire danni permanenti all'udito.
L'ipoacusia improvvisa può essere un sintomo associato a diversi tipi di tumori, tra cui il neurinoma acustico, un tumore benigno che colpisce il nervo acustico nell'orecchio interno. Altri tumori che possono causare ipoacusia improvvisa includono meningiomi, linfomi, mielomi e leucemie, anche se in misura meno comune.
Questi tumori possono esercitare pressione sui nervi uditivi o sulle strutture dell'orecchio interno, compromettendo così la trasmissione dei segnali uditivi al cervello e causando una graduale perdita dell'udito o un improvviso calo uditivo. Poiché l'ipoacusia improvvisa può essere un segno precoce di un tumore, è essenziale consultare immediatamente un medico se si verifica un cambiamento improvviso nell'udito, specialmente se accompagnato da altri sintomi come vertigini, disturbi dell'equilibrio o acufeni.
La diagnosi precoce e il trattamento tempestivo dei tumori possono migliorare significativamente le prospettive di recupero dell'udito e la gestione complessiva della condizione oncologica.
La ricerca scientifica continua a valutare attentamente i potenziali effetti collaterali dei vaccini Covid-19, compresa la relazione tra la vaccinazione e l'ipoacusia improvvisa. Uno studio pubblicato su JAMA (Journal of the American Medical Association) ha esaminato i casi di perdita uditiva segnalati dopo la vaccinazione Covid-19. Questo studio ha evidenziato che, sebbene alcune persone abbiano riportato perdita uditiva dopo la vaccinazione, non c'è stata una chiara evidenza di una relazione causale diretta tra la vaccinazione e l'ipoacusia improvvisa.
Gli autori hanno sottolineato che è necessaria ulteriore ricerca per comprendere appieno la natura di questi casi e stabilire eventuali correlazioni causali. In più, gli effetti collaterali sono generalmente lievi e transitori.
La perdita improvvisa dell'udito negli anziani è una condizione che richiede una valutazione accurata e tempestiva, poiché può avere un impatto significativo sulla qualità della vita e sulla salute generale. Anche se l'ipoacusia improvvisa è più comunemente associata agli adulti più giovani, può verificarsi anche negli anziani per una serie di motivi. Alcuni dei fattori che possono contribuire alla perdita improvvisa dell'udito negli anziani sono:
I sintomi dell'ipoacusia improvvisa possono variare da persona a persona e dipendono dalla gravità e dalla causa sottostante della perdita uditiva. Tuttavia, ci sono alcuni sintomi comuni che possono essere associati a questa condizione. Eccoli:
La terapia primaria per l’ipoacusia improvvisa è solitamente rappresentata dalla somministrazione di cortisonici e vasoattivi per via orale o endovenosa e, in alcuni casi, diuretici. In caso di risposta scarsa o assente, è consigliato l’utilizzo dell’ossigeno-terapia iperbarica (OTI).
L’ossigenoterapia iperbarica incrementa sensibilmente la pressione parziale di ossigeno nel sangue e, per diffusione, nei liquidi dell’orecchio interno, stimolando il metabolismo cellulare delle strutture cocleari e vestibolari, anche in condizioni di scarso apporto di sangue. In seguito a queste considerazioni l’ossigenoterapia iperbarica è stata proposta quale terapia in caso di ipoacusia improvvisa. Il razionale della terapia si basa sull’ipotesi che il deficit uditivo e l’eventuale acufene siano conseguenti ad una lesione ipossica delle strutture cocleari e che la somministrazione di ossigeno iperbarico possa indurre una regressione del danno.
Diversi studi hanno evidenziato che i pazienti sottoposti a trattamento OTI entro 30 giorni dall’insorgenza del danno hanno una risposta migliore. Questi stessi studi hanno dimostrato come l’OTI, somministrata entro 30 giorni e non oltre i tre mesi dall’insorgenza dell’ipoacusia, può rappresentare una valida possibilità terapeutica nel caso in cui non vi sia una buona risposta alla terapia convenzionale.
Malgrado i tanti anni di utilizzo della OTI e la cospicua letteratura in merito al suo beneficio nel trattamento delle sordità improvvise, l’assenza di una accurata metodica nella selezione della popolazione, nelle modalità di trattamento e nella elaborazione statistica dei risultati fa sì che venga a mancare una effettiva evidenza clinica dell’efficacia del trattamento, sia utilizzata inizialmente in associazione alla terapia steroidea sia successivamente nelle forme resistenti.
In contrapposizione ai probabili effetti positivi va detto che l’ossigenoterapia iperbarica può indurre effetti citotossici per la modificazione degli agenti antiossidanti normalmente presenti nei tessuti. Tuttavia è dimostrato come tali effetti collaterali siano minimizzati qualora la OTI avvenga in ambiente compreso tra le 2 e le 3 atmosfere e per un tempo inferiore ai 90 minuti.
La OTI può indurre la comparsa di effetti collaterali considerati minori: disturbi del visus caratterizzati solitamente da una riduzione della acuità visiva; l’insorgere di sinusopatie e disfunzioni tubariche correlate alle variazioni pressorie a carico delle vie aeree superiori in soggetti predisposti per la presenza di flogosi di tali mucose; disturbi neurologici di lieve entità. Tutte queste reazioni collaterali sono segnalate come rapidamente reversibili al termine della terapia e non richiedono interventi particolari.
L’impianto fondamentale per praticare la terapia iperbarica è costituita da una camera di decompressione che è un apparato in grado di sopportare una elevata pressione di aria al suo interno e che permette di ospitare persone che abbiano la necessità di essere sottoposte al trattamento iperbarico, sia per l’ipoacusia improvvisa che per altre diverse patologie per le quali tale terapia è stata inizialmente proposta (infezioni da germi anaerobi, avvelenamento da monossido di carbonio, patologie da decompressione in subacquei, etc).
Il trattamento viene effettuato introducendo i pazienti in camera iperbarica, fornendoli di una mascherina a circuito chiuso che eroga ossigeno puro, e incrementando la pressione interna della camera così da provocare un aumento della pressione parziale di ossigeno nei tessuti. Il trattamento non è standardizzato, ma il protocollo di terapia può essere diversificato tra i vari centri. Il paziente viene sottoposto a una o due sedute giornaliere della durata di 60 minuti.
Generalmente il protocollo di OTI nelle sordità improvvise, prevede un ciclo iniziale di 8 sedute della durata di complessiva di 85 minuti (2 fasi, intervallate, ciascuna con erogazione di ossigeno puro della durata di 36’) a 2,5 ATA. Dopo il primo ciclo si procede a rivalutazione audiometrica e, ove vi fossero i margini di ulteriori effetti positivi si prosegue la terapia per altre 8 sedute.
L'uso del cortisone è una delle opzioni di trattamento comuni per la sordità improvvisa, soprattutto quando questa è considerata idiopatica, cioè senza una causa identificabile. Il cortisone può essere prescritto per via orale o somministrato tramite iniezione direttamente nell'orecchio interno.
Il motivo principale per cui il cortisone viene utilizzato nel trattamento dell'ipoacusia improvvisa è il suo potenziale effetto antinfiammatorio. Si ipotizza che l'infiammazione nell'orecchio interno possa giocare un ruolo nel causare o contribuire alla perdita improvvisa dell'udito. Il cortisone può aiutare a ridurre questa infiammazione e a migliorare il flusso sanguigno nell'orecchio interno, facilitando così il recupero dell'udito.
Tuttavia, l'uso del cortisone nel trattamento dell'ipoacusia improvvisa rimane oggetto di dibattito tra gli esperti medici. Alcuni studi hanno mostrato benefici significativi nell'uso del cortisone, soprattutto se somministrato precocemente dopo l'insorgenza dei sintomi. Tuttavia, altri studi hanno evidenziato risultati meno consistenti, suggerendo che il cortisone potrebbe non essere efficace per tutti i pazienti.
Come con qualsiasi trattamento, ci possono essere rischi e potenziali effetti collaterali associati all'uso del cortisone. È importante che la decisione di utilizzare il cortisone nel trattamento dell'ipoacusia improvvisa venga presa in consulto con un medico specialista, che valuterà attentamente i potenziali benefici e rischi in base alla situazione clinica specifica del paziente.
I centri specializzati nell'ipoacusia improvvisa sono strutture mediche che offrono diagnosi, trattamenti e supporto specializzato per le persone che affrontano questa condizione uditiva. Questi centri sono solitamente gestiti da otorinolaringoiatri (ORL) o audiologi esperti nel trattamento delle malattie dell'udito. Alcuni dei servizi che potrebbero essere offerti nei centri specializzati nell'ipoacusia improvvisa comprendono:
Per individuare un centro specializzato nell'ipoacusia improvvisa, è consigliabile consultare un medico di fiducia o un otorinolaringoiatra che possa fornire indicazioni specifiche sulla base delle esigenze individuali del paziente e della localizzazione geografica.
Molte persone hanno provato l'ipoacusia improvvisa, un'esperienza che può essere sia spaventosa che frustrante. Quando si verifica, può capitare all'improvviso e senza preavviso, lasciando le persone con una sensazione di confusione e isolamento. La perdita improvvisa dell'udito può rendere difficile la comunicazione e partecipazione alle attività quotidiane.
Con il tempo, il trattamento e il sostegno adeguato, molte persone hanno sperimentato un miglioramento della loro capacità uditiva e una maggiore qualità di vita. È un percorso che può essere difficile, ma con il supporto della famiglia, degli amici e dei professionisti medici, molte persone hanno affrontato la sfida con determinazione e speranza.
Si deve contattare un otorino il prima possibile se si verificano improvvisamente i sintomi precedentemente elencati. Il medico effettuerà una serie di esami per diagnosticare l'ipoacusia improvvisa. Viene utilizzato il processo del principio di esclusione. Con questa procedura si escludono possibili malattie dell'orecchio prima che venga diagnosticata un'improvvisa perdita dell'udito.
Innanzitutto, l'otorino effettua un'anamnesi dettagliata, oltre alle domande sul suo stato di salute generale, al paziente vengono poste anche domande specifiche su problemi di udito pregressi e comparsa dei sintomi. In seguito, se necessari, si potranno effettuare ulteriori esami che forniscono informazioni sulla funzionalità delle orecchie:
L'aumento della pressione sanguigna, un aumento del livello di colesterolo, l'obesità, l'aumento del consumo di nicotina ma anche il diabete sono responsabili del verificarsi di un'improvvisa perdita dell'udito.
Se la perdita dell'udito è stata causata da un disturbo circolatorio, dovrebbero essere seguite le stesse misure raccomandate per prevenire un infarto:
Inoltre, per quanto possibile bisognerebbe non esporsi a rumore eccessivo. In situazioni in cui ciò non può essere evitato, come concerti o discoteche, si consiglia di indossare protezioni acustiche.
Volare, nuotare, immergersi: quali azioni sarebbe saggio evitare in caso di improvvisa perdita dell'udito?
Fondamentalmente, dovresti discutere con il tuo medico quali attività sarebbe meglio evitare se hai un'improvvisa perdita dell'udito. Durante un volo, ad esempio, molte persone sperimentano una sensazione di disagio nelle orecchie a causa dell'equalizzazione della pressione nella cabina di volo, fenomeno che può avvenire anche durante un'immersione. In altre parole, queste situazioni sono particolarmente impegnative per le nostre orecchie, quindi sarebbe consigliabile evitarle durante un fenomeno di ipoacusia improvvisa.
Inoltre, non è consigliabile fare esercizio durante un'improvvisa perdita dell'udito. Tutto ciò che è troppo faticoso dovrebbe assolutamente essere evitato, favorendo il riposo ed evitando situazioni di stress.
Scopri gli altri contenuti dedicati alla slaute uditiva, preparati dai nostri esperti per te. Puoi anche consultare il nostro magazine online, aggiornato con le ultime novità.